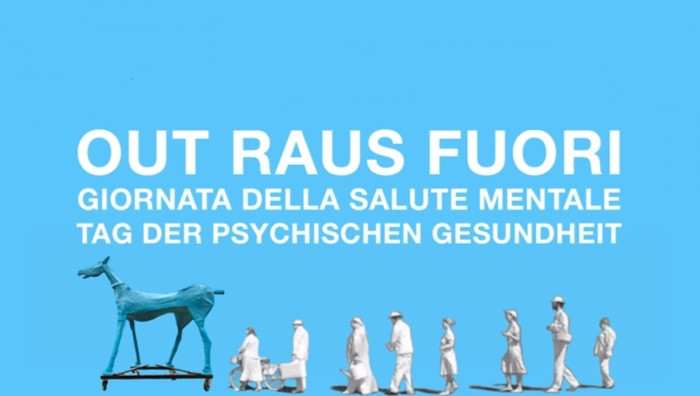di Antonio Lasalvia
Gentile Direttore,
il nuovo Piano d’Azione per la Salute Mentale 2025–2030 rappresenta un passo rilevante e atteso, a oltre dieci anni di distanza dal precedente documento di indirizzo (2013). Il contesto attuale – segnato da eventi epocali come la pandemia da COVID-19, l’aumento delle disuguaglianze, la transizione digitale e le sfide climatiche – ha profondamente modificato i bisogni di salute mentale e richiede risposte aggiornate, sistemiche e innovative. In questo senso, la pubblicazione del PASM costituisce un’opportunità preziosa per ridefinire priorità e strategie.
Tuttavia, nonostante l’aggiornamento fosse atteso e necessario, il documento appare in alcuni punti ancorato a un lessico e a un impianto concettuale non completamente allineati agli sviluppi internazionali più recenti e alle migliori pratiche documentate. I commenti al Pansm che seguono non intendono essere esaustivi o sistematici. Si concentrano esclusivamente su alcuni aspetti del documento rispetto ai quali ho maturato negli anni una particolare attenzione e sensibilità, tralasciandone altri che, pur rilevanti, meriterebbero anch’essi una riflessione.
Stigma e discriminazione: un tema trattato in modo superficialeIl tema dello stigma legato ai disturbi mentali, pur riconosciuto come rilevante nella cornice introduttiva, viene affrontato in modo generico e superficiale (“Lo stigma interiore può essere fonte di grave disabilità, il disagio psichico rende le persone fragili e vulnerabili nei diversi contesti di vita”). I riferimenti alle azioni di contrasto sono limitati a enunciazioni di principio (es. “favorire l’inclusione e contrastare stigma e discriminazione”).
La questione viene sommariamente trattata in un breve paragrafo del Capitolo 5 “Salute Mentale e Integrazione Socio-Sanitaria” (pagina 83), nella parte dedicata alle “Criticità dell’integrazione sociosanitaria”. Né in questo paragrafo, né altrove nel testo, si fa riferimento ad azioni concrete di superamento dello stigma, come:
- strategie operative specifiche;
- indicatori misurabili;
- interventi strutturati e finanziati.
Manca ogni riferimento a programmi anti-stigma evidence-based, sia internazionali che nazionali, né si indica come integrare il contrasto allo stigma nella formazione, nelle pratiche cliniche, nei percorsi di recovery o nei servizi per adolescenti e giovani adulti. Una dimenticanza rilevante, soprattutto considerando la disponibilità di solide evidenze scientifiche e indicazioni operative facilmente implementabili, come illustrato nel Mosaic toolkit to end stigma and discrimination in mental health, pubblicato dalla WHO Regional Office for Europe nel 2024 (di cui ho curato l’edizione italiana di prossima uscita).
Il Pansm non prevede la realizzazione di un’indagine conoscitiva a livello nazionale sullo stigma verso i disturbi mentali. In Italia, a differenza di quanto accaduto negli ultimi vent’anni in numerosi Paesi europei ed extraeuropei, non sono mai state condotte indagini esaustive e rappresentative su scala nazionale riguardo a conoscenze, opinioni e atteggiamenti della popolazione generale verso le persone con disturbi mentali. La mancanza di tali dati rappresenta una lacuna critica, che ostacola la possibilità di comprendere appieno la dimensione del fenomeno e sviluppare strategie di contrasto efficaci.
Il Pansm non menziona lo stigma presente all’interno degli stessi servizi di salute mentale, come invece ampiamente documentato dalla letteratura italiana e internazionale. Atteggiamenti inconsapevoli di rifiuto, invalidazione, paternalismo, pessimismo prognostico e scarsa attitudine negoziale possono riflettere visioni stereotipate e pregiudiziali, disincentivando l’ingaggio degli utenti, favorendo l’abbandono dei trattamenti e alimentando il fenomeno degli “inspiegabili” dropout, spesso attribuiti in modo semplicistico alla mancanza di insight del paziente.
È stata persa anche l’occasione di indicare come cogente la realizzazione di una campagna nazionale anti-stigma strutturata, finanziata e dotata di indicatori di impatto. In molti Paesi si realizzano campagne nazionali coordinate e valutate – tra cui Time to Change (Regno Unito), One of Us (Danimarca) e Obertament (Spagna) – che rappresentano esempi virtuosi e modelli replicabili.
Co-produzione e co-progettazione: uno spazio ancora marginale
Un’altra carenza rilevante riguarda l’assenza di una visione chiara e strutturata sulla co-progettazione dei servizi. Il coinvolgimento attivo e sistemico di utenti, familiari, cittadini, terzo settore e comunità nella pianificazione, valutazione e governance è un pilastro dei sistemi più evoluti, ma nel Pansm 2025–2030 il tema è appena accennato e non trova alcuna traduzione operativa:
- non vengono delineati modelli di governance partecipata;
- mancano strumenti per favorire la partecipazione degli stakeholder nella programmazione e valutazione dei servizi;
- non si propone una visione sistemica e continuativa della partecipazione.
L’assenza di riferimenti al documento dell’OMS WHO framework for meaningful engagement of people living with noncommunicable diseases, and mental health and neurological conditions (2023) è particolarmente significativa. Questo documento propone un quadro operativo per il coinvolgimento significativo nei processi decisionali, non solo in ambito salute mentale. È sorprendente che un orientamento così rilevante non venga nemmeno menzionato.
Valorizzazione del sapere esperienziale e ruolo degli ESP
Il riferimento agli Esperti in Supporto tra Pari (ESP) compare nel Capitolo 5, elencato tra i “Interventi mirati all’inclusione sociale” (pagina 80). Sebbene sia apprezzabile che il documento li citi esplicitamente, non ne viene colto il potenziale trasformativo. L’integrazione del sapere esperienziale non è una semplice misura aggiuntiva, ma una leva paradigmatica di cambiamento, come evidenziato dalla letteratura recente.
Nel Pansm, la figura degli ESP viene menzionata senza che vengano analizzati:
- il potenziale trasformativo per i servizi;
- i requisiti formativi;
- le condizioni per l’inserimento strutturale nei servizi.
Gli ESP non sono presentati come agenti di cambiamento del modello organizzativo e culturale, come invece avviene nei piani strategici di altri Paesi o nelle raccomandazioni OMS. Da segnalare, in particolare, la recente pubblicazione Transforming mental health through lived experience: roadmap for integrating lived and living experience practitioners into policy, services and community (OMS Europa, 2025), che evidenzia come l’inclusione sistemica degli ESP sia cruciale per realizzare sistemi realmente orientati alla recovery. Gli ESP colmano il divario tra istituzioni e persone, umanizzano la cura e promuovono inclusione.
Scarsa attenzione agli aspetti etici e ai trattamenti senza consenso
Il Pansm non affronta in modo adeguato le questioni etiche centrali nel trattamento delle persone con disturbi mentali: proporzionalità delle cure, trasparenza delle decisioni, consenso informato, tutela della dignità, riduzione della coercizione e della contenzione fisica. Il tema del consenso viene solo sfiorato in un paragrafo sul risk management (pagina 61), senza alcuna analisi critica.
Non vi è alcun riferimento ai fondamentali documenti OMS come:
- WHO Guidance on Community Mental Health Services (2021);
- Mental health, human rights and legislation: guidance and practice (2023).
Entrambi promuovono un approccio centrato sulla persona e rispettoso dei diritti umani, in linea con la CRPD. Il PASM, invece, affronta in modo marginale temi cruciali come:
- Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): trattato solo dal punto di vista normativo nel paragrafo sulla “Collaborazione con le Forze dell’Ordine” (pagine 68–69), e limitatamente alla sicurezza degli operatori;
- Coercizione: menzionata una sola volta, senza alcuna riflessione critica o proposta di riduzione;
- Contenzione fisica: citata di sfuggita in una tabella del Capitolo 4, con l’invito a monitorare e ridurre il fenomeno, ma senza strategie di de-escalation, alternative evidence-based o programmi di eliminazione graduale.
Conclusione Il PASM 2025–2030 rappresenta un importante passo verso il rinnovamento delle politiche nazionali in salute mentale, ma presenta lacune significative in relazione a stigma, partecipazione, sapere esperienziale e diritti. È evidente che un documento strategico di indirizzo non possa essere esaustivo, e che debba concentrarsi su alcune priorità. Ma proprio per questo è lecito domandarsi: la questione etica in salute mentale è, o no, una priorità in questo Paese?
La scarsa attenzione che spesso si riscontra nel nostro sistema di cura su questi aspetti – che rappresentano lo sfondo valoriale e fondativo del fare salute mentale – solleva interrogativi profondi. La modellistica organizzativa, la questione delle REMS o la carenza di risorse, per quanto cruciali, non possono sovrastare la centralità della persona, dei diritti e della partecipazione.
Affinché il Piano possa realmente fungere da guida strategica e trasformativa, sarà indispensabile rafforzare e integrare i temi indicati in una fase successiva di revisione o attuazione. Altrimenti, il rischio è quello di produrre un documento aggiornato solo formalmente, ma incapace di guidare una vera innovazione dei servizi e delle politiche per la salute mentale.
Antonio Lasalvia
Professore Associato di Psichiatria Università di Trento
Direttore UO Psichiatria Distretto Sud, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento
Fonte: Quotidiano Sanità